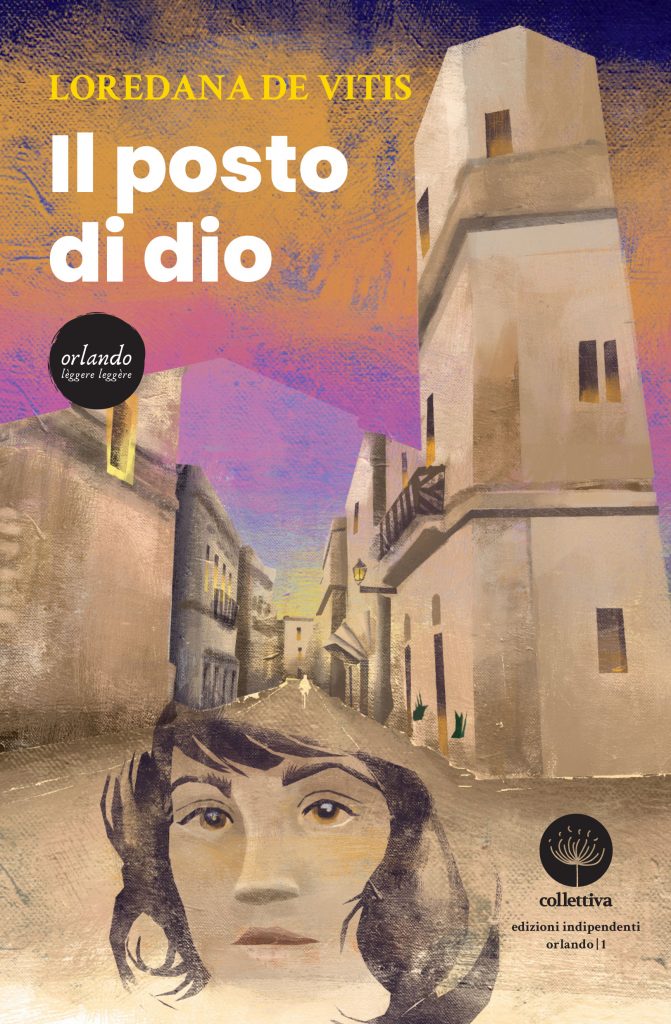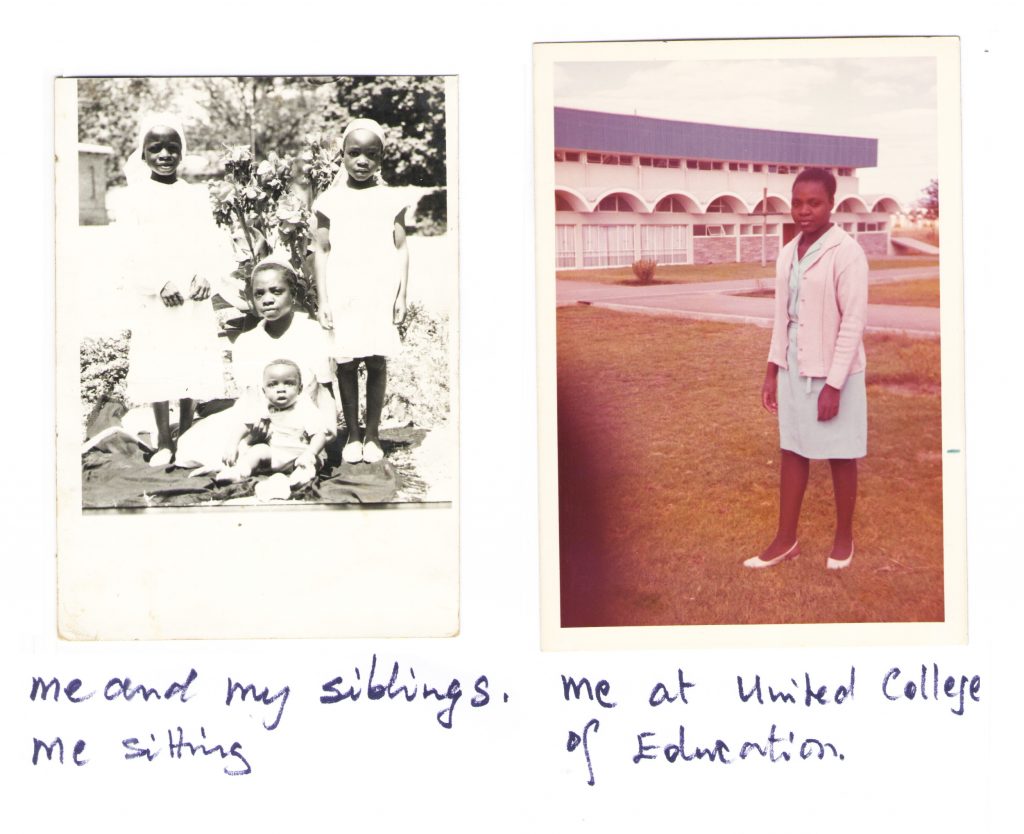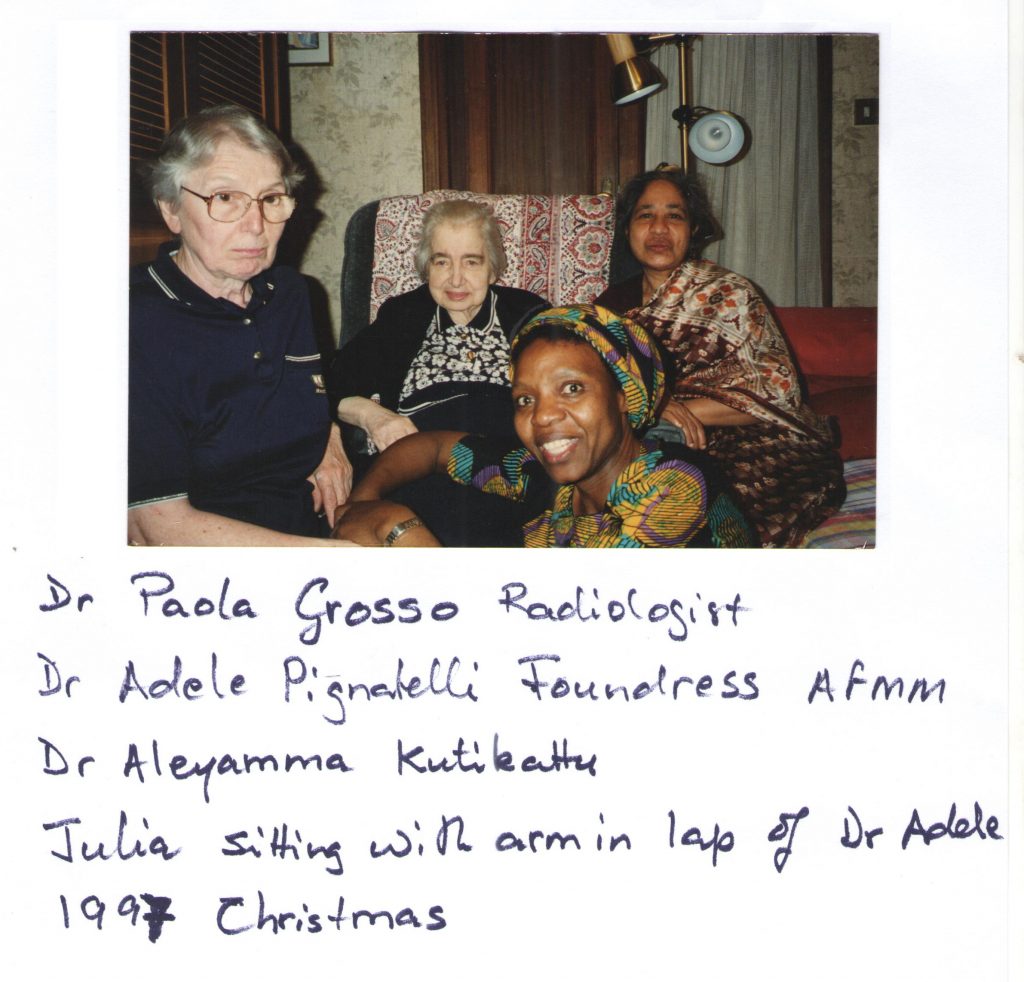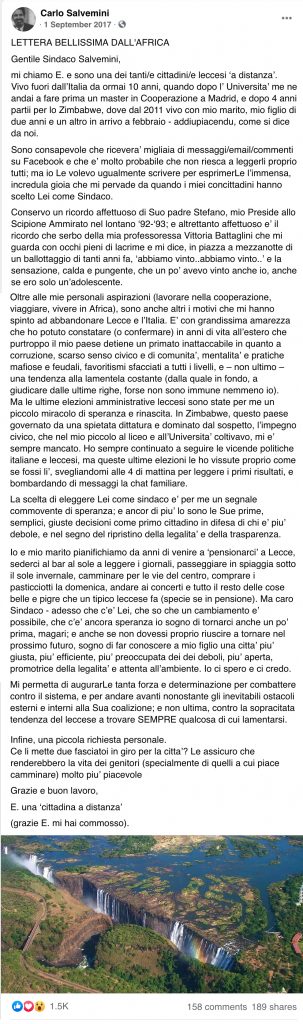avvertenza: in questo testo ho inserito numerosi riferimenti a cose/luoghi/persone che do per scontati, confido nella semplicità con cui si cerca su google
Seguo Lea Barletti come autrice. Autrice di testi, testi teatrali, testi narrativi, autrice di testi anche quando li recita. Non so distinguere le sue messe in scena dalla sua scrittura. Nei giorni scorsi ho visto a Lecce “Autodiffamazione”, “Parla, Clitemnestra!”, “Monologo della Buona Madre” e “Ashes to Ashes”, quattro spettacoli in tre giorni firmati dalla compagnia sua e di Werner Waas: attualmente vivono a Berlino e sono tornati brevemente qui, dove anni fa hanno tra l’altro contribuito a fondare le Manifatture Knos, per una “personale” al Teatro Koreja. La parola “personale” non l’ho scelta io, ma è mia l’associazione immediata con una mostra d’arte. E questa tre giorni per me lo è stata. Ecco perché.
Barletti/Waas lavora sulla parola-in-relazione, e su questo concetto costruisce l’universo del suo teatro: recitato, scene, costumi, musica. “Un discorso sul mondo” lo chiamano: «Non ci interessa parlare di noi, ci interessa parlare attraverso di noi, attraverso i nostri corpi, le nostre lingue, del mondo», scrivono per presentarsi, «Ci interessano testi attraverso i quali rendere possibile questo discorso, ci interessa farci portatori e testimoni di quei testi, essere strumento del testo e al contempo usare il testo come strumento».

Autodiffamazione
Autodiffamazione parte da un testo di Peter Handke [peraltro co-autore della sceneggiatura de “Il cielo sopra Berlino”, credo uno dei miei film preferiti, ma non è rilevante – mi rendo conto]: lo ha scritto a 24 anni, 57 anni fa, Barletti e Waas l’hanno in parte ri-tradotto in italiano, considerando inefficace la traduzione più nota, e lo portano in scena da dieci anni. Circa ottanta le repliche. Entrano in scena nudi eccetto che per due dettagli: lei porta scarpe con tacchi alti, lui un cappello. Poi si vestono e continuano ad auto-diffamarsi parlando in due lingue, ciascuno nella sua lingua madre – italiano e tedesco, ciascuna delle due lingue viene alternativamente sovratitolata. Si auto-accusano di cose piccole, minuscole, di cose che diventano colpe anche se non lo sono, di cose che abbiamo fatto tutti/e o che, se non abbiamo fatto, ci riguardano lo stesso. Impressionante, per me, la scelta di tradurre un passaggio con l’espressione “ho violato il lockdown”. Ecco, in quel momento l’abbattimento del “confine” tra generi, tra attori e spettatori, tra passato e presente per me è stato totale. Passano i minuti e ti scordi che sei lì per osservare e ascoltare, sul palco ci sei salita, parli in italiano, parli in tedesco, sei donna, sei uomo, sei un/a vivente qualsiasi e in questa generalizzazione c’è tutta la bellezza e tutto il dramma della condizione umana. Alfa e omega dello spettacolo [e della vita, no?] sono in questa affermazione: “Io sono venuto al mondo”. In un breve dialogo col pubblico dopo lo spettacolo, Waas ha osservato: «L’io è sopravvalutato, e senza le regole resterebbe ben poco», rivelando un grande lavoro umano e artistico a partire da Handke. E poi Barletti: «(L’autodiffamazione) è un metodo, un congegno per pensare».

Parla, Clitemnestra! Un’eterna tragedia in versi
Un congegno a mio parere chiaro anche in Parla, Clitemnestra! Un’eterna tragedia in versi, scritto da Lea Barletti, portato in scena assieme a Gabriele Benedetti, regia Barletti/Waas. Barletti-Clitemnestra accanto a Benedetti-Agamennone sul palco, pelle dipinta di bianco e coperta di panni bianchi, è un’icona: la sua scrittura si fonde con gesti e voce per ri-narrare il personaggio classico della moglie fedifraga e assassina e poi della madre assassinata. Una nuova storia si costruisce letteralmente illuminata dal pubblico, e quindi narrata anche in questa “relazione”: in 90 circondiamo la scena, quattro di noi illuminano i personaggi con piccole torce e sottolineano dettagli, creano ombre, ci condizionano, ci irritano a volte. Da principio Barletti-Clitemnestra parla lentamente, si “poggia” su ogni parola, la sottolinea muovendosi piano, rivendica una storia di dolore giocando coi registri. Il testo è in rima, “una gabbia che libera” la definisce l’autrice, alleggerisce il peso di una storia conosciuta eppure mai narrata. Poi la lingua e i gesti man mano di sciolgono, dal passato si giunge al presente, a quello di molte donne violate, a quello di tutte le donne che aderiscono coscienti o incoscienti a schemi dell’essere e dell’agire. Beh, da questa dinamica Agamennone – le cui colpe sono chiare, evidenti, ribadite – non esce come unico colpevole. Perché gli schemi reggono finché l’uno si regge sull’altro, finché si sostengono a vicenda, finché si gioca quel gioco che si conosce fin troppo bene e in cui è facile sentirsi, paradossalmente, al sicuro.

Monologo della Buona Madre
In Monologo della Buona Madre il gioco dentro-fuori dagli schemi arriva al suo picco. Scritto e interpretato da Lea Barletti, regia Barletti/Waas, è punteggiato dalle musiche originali – perfette – di Luca Canciello. Chi parla in questo monologo? La donna, l’autrice, l’attrice? Che domande sono? Cosa significano? Nulla, zero. Quello che importa per me è l’energia che ti resta.
Cosa so fare io? So fare dolci, si chiede e si risponde Barletti-BuonaMadre, abito nero, tacchi, mani sulle ginocchia, seduta ad almeno tre metri da terra come una statua: sul piedistallo la scritta “Buona Madre, tecniche e materiali misti”. Waas passa tra gli spettatori offrendo biscotti e a me vengono in mente tanti dei dolci e biscotti postati da Barletti su Facebook. Mi viene in mente soprattutto il post per uno dei compleanni di uno dei loro figli [Hanno fatto due figli, insieme, scrivono sul loro sito]: una torta a forma di morte nera. Miodio, difficilissimo, avevo pensato.
[Continuo adesso col ricordo dello spettacolo, a braccio].
Cosa ho insegnato ai miei figli? A cucinare il sugo? Quello lo potevano imparare a fare anche da soli, come ho fatto io. Mi sono venute in mente le prime settimane, densissime, della mia esperienza di madre. Leggevo, leggevo molto [non mi ricordo però né quando né come], soprattutto cose che mi hanno aiutata a capire che tipo di madre non “volevo” essere, ma “sentivo” di essere. Non perfetta, questo no, nemmeno mi importava. Ma “abbastanza buona”, questo sì. Abbastanza. Coi miei limiti. Che mi danno grande bellezza, che mi rendono unica. Barletti-BuonaMadre scrive ed è questo il suo lascito perfetto. La gabbia della perfezione è la stessa del bisogno di sentirsi amata, ma per amarsi bisogna essere liberi, o almeno aspirare a esserlo, nei continui aggiustamenti del quotidiano. Liberi di dirsi le cose, dirle a sé e dirle agli altri. In certi passaggi dolorosi del monologo un pensiero leggero mi ha attraversata: lascia perdere, questa è una sciocchezza, una fesseria, lascia perdere, non è importante. A chi lo dicevo? Lo dicevo a me stessa, senza alcun dubbio.
«Il teatro è l’unica cosa che so fare», ha detto Barletti dopo lo spettacolo. Io avrei detto scrivere, ma non cambia niente. È abbastanza. È più che abbastanza.

Ashes to Ashes
La personale si è chiusa con la prima nazionale di Ashes to Ashes, cenere alla cenere, scritto da Lea Barletti, in scena Werner Waas, regia Barletti/Waas e, anche in questo caso, le ottime musiche originali di Luca Canciello. Il teatro è denso di fumo, prodotto all’inizio anche dal cappello del personaggio-pagliaccio-uomo-automa che percorre il palco a due e quattro zampe, che impugna un microfono e una banana, che siede tra il pubblico, che esce ed entra ricordandoci che la terra è in fiamme. Che tutto diventa cenere mentre discutiamo della pasta che scuoce, che brucia tutto fuori e anche dentro di noi. Brucia la nostra capacità di pensare, di agire, di decidere, di preoccuparci davvero di ciò che ci circonda, di distinguere il vero dal falso, il reale dall’immaginato. Torna pure l’ironia che però, questa volta, invece che alleggerire ci fa sprofondare nella disperazione. Li ho odiati, a un certo punto, per avermi costretta a ripensare all’impotenza che sento e che, a volte, non mi ha fatto dormire. Io voglio dormire, non voglio tornare a ricordare quanto ogni piccolo gesto può essere influente su ciò che accade al pianeta che mi fa vivere e al quale sono debitrice.
Parole politiche, insomma, programmaticamente proposte per richiamare al pensiero. Pensate, persone!, pensate. Come tutto il teatro, direte. Forse. Non ne sono sicura. Mi piace il fatto che Barletti/Waas non dia risposte, che faccia solo domande.
[pausa]
Ho chiesto a Lea Barletti di leggere questo testo e di rispondere a tre domande. Eccole.

Tre domande a Lea Barletti
Ho provato a immaginarmi come e dove scrivi, è una questione che quasi mi ossessiona da quando mi sono resa conto che, anche avendo “una stanza tutta per sé”, questa non è sufficiente: perché devi avere anche il tempo e la calma di abitarla, quella stanza. Dopo aver letto i tuoi racconti in “Libro dei dispersi e dei ritornati” (Musicaos 2018), scritti a partire da foto trovate per caso, e questa immersione nella vostra personale a Lecce, vorrei proprio saperlo: dove e come scrivi? La domanda anela a una risposta che nutre aspettative verso la tua capacità di raccontare la materialità della vita senza perdere l’astrazione.
La prima “scrittura” la faccio per lo più in mente. Camminando all’aperto, possibilmente in luoghi vasti (ma mi adatto, l’importante è che si veda il cielo). Mi piace camminare, quasi quanto detesto invece andare in bicicletta. Esco e cammino, a volte anche per diversi chilometri. I pensieri, le parole, le frasi, seguono il ritmo del corpo in movimento e del respiro e ad un certo punto non c’è più distinzione tra parole e corpo, tra pensiero e movimento. Soprattutto molti testi in versi sono nati così. La mia è una scrittura che nasce soprattutto dal corpo, come se le sillabe o le parole si appoggiassero sul movimento e viceversa. Il ritmo, in questo senso, è in qualche modo più importante del senso. È il ritmo che guida, e nasce dal corpo.
Poi, a casa, trascrivo al computer quello che mi ricordo. A volte purtroppo alcune cose vanno perdute, ma pazienza, quelle fondamentali restano, come inscritte nella memoria del corpo. Trascrivendole, quindi ri-pensandole, possono cambiare, spesso scopro altre cose, è un procedimento vivo, non cerco di “fermarle” sulla carta, cerco piuttosto di continuare a sentirne il movimento. A casa, più classicamente, scrivo al tavolo della cucina. Alla mia sinistra c’è la finestra che da sul giardino. Questo mi aiuta a vincere una leggera forma di claustrofobia: devo sempre avere la possibilità di vedere un pezzo di cielo, proprio come quando cammino. Ma anche al computer, è una questione di ritmo: anche qui è il ritmo, con il movimento e il rumore delle dita sui tasti, che mi guida.
Nei tuoi testi le parole mi paiono pesate [letteralmente], anche se non mancano la velocità e un certo… effetto “spontaneità”. È così? Perché?
Sì, in scena le parole sono pesate, perché le penso o ri-penso, dunque le peso, ogni volta che le pronuncio. È quasi lo stesso procedimento di “trascrizione” che faccio quando passo dal testo “pensato” a quello scritto, cercando di ascoltare il movimento delle parole e di trascriverlo. A loro volta, poi, le parole che ho scritto, passando nuovamente per il corpo per essere pronunciate sulla scena, vengono ri-pensate e ri-pesate e in questo modo ri-scoperte ogni volta diverse, nuove. E assumono un nuovo ritmo, un nuovo movimento, un nuovo senso, a volte vicino a quello che le ha originate, come delle “variazioni”, a volte stravolgendolo in una nuova visone. Le parole per me sono porte che si aprono su possibilità ogni volta diverse, e queste possibilità si rivelano solo se do loro la possibilità di rivelarsi, solo se mi pongo, io per prima, come autrice e come attrice, in una posizione di ascolto. Le parole sono vive, anche quelle scritte, perché leggendole, pensandole, ascoltandole e dicendole rivelano sempre qualcosa di nuovo. Leggendo, lo stesso processo lo facciamo, da lettori, nella mente. O almeno: da lettori “attivi”. E lo stesso avviene negli spettatori. L’attore è in questo senso un tramite del testo, l’attore ascolta e lascia agire dentro di sé il testo che arriva vivo allo spettatore che a suo volta lo ascolta e lascia agire dentro di sé e lo restituisce, con il suo ascolto, sguardo, presenza, all’attore. E così via. Il teatro è per me un pensare insieme, un circolo virtuoso.
Ho letto sul vostro sito un testo di Werner a proposito di Autodiffamazione. Dice: All’inizio c’era l’entusiasmo di Lea, sempre di nuovo quel suo entusiasmo! per La notte della Morava. E poi c’era quel suo pluriennale insistere, ossessivo, ininterrotto, perché tirassi fuori un testo, un progetto sul quale lavorare e scappare così dalle contingenze quotidiane e dal vuoto che ci stava per inghiottire. In fondo non avevamo più fatto nulla di veramente degno di nota dalla nostra Anarchia in Baviera due anni prima. Io non avevo voglia di fare niente, non avevo nessun’idea in grado di mettere in moto qualcosa e assistevo impotente allo sgretolarsi del nostro rapporto.
Assistere alla vostra personale è stato anche un viaggio intimo, mi sono sentita destinataria del racconto di un’intimità condivisa, ché l’arte è il massimo dell’intimo possibile credo. Convergono nei tuoi testi, prodotti e resi in scena dalla vostra compagnia, fatti privati e questioni pubbliche senza che si possa distinguere una linea di confine. O c’è? In un caso e nell’altro, cosa c’è di confortevole e cosa di complesso nel vostro lavoro comune?
Su molte, moltissime, cose ci capiamo al volo. Abbiamo un vocabolario in comune. Ci fidiamo l’uno dell’altra, contiamo sulla reciproca capacità di ascolto e restituzione. Siamo come “allenati” a pensare insieme. E questo è confortevole e complesso allo stesso tempo.
Poi, come tutte le coppie artistiche e/o di vita, discutiamo, e anche litighiamo, spesso. Ma solo fuori dalla scena. In scena no, mai. In scena l’accordo, l’ascolto, il dialogo sono quasi sempre perfetti, il canale di comunicazione è aperto e sgombro da ostacoli, il maggiore dei quali è il proprio e altrui ego. In scena cerchiamo per quanto possibile di tenere l’ego da parte. Nella vita, come per tutti, a volte è più difficile, a volte il canale si chiude, l’ego si mette in mezzo e impedisce il vero reciproco ascolto, e quindi il dialogo. Forse in questo caso la vita avrebbe qualcosa da imparare dall’arte? Con Werner crediamo che un attore debba essere trasparente, e la trasparenza è possibile solo se l’ego non si mette per traverso impedendo allo spettatore di “vedere”, ATTRAVERSO l’attore, la propria storia, fare il proprio percorso, la propria esperienza. Ecco questo è quello che intendiamo noi per “fare teatro”: la possibilità di un dialogo. E perché ciò avvenga tra noi e gli spettatori, questo dialogo, vivo, attivo, deve avvenire innanzitutto all’interno di noi e tra di noi.
Per saperne di più sulla compagnia Barletti/Waas: https://barlettiwaas.eu/
una cosa che ho fatto con Lea Barletti
in copertina: Monologo della buona madre, ph. Luciano Onza