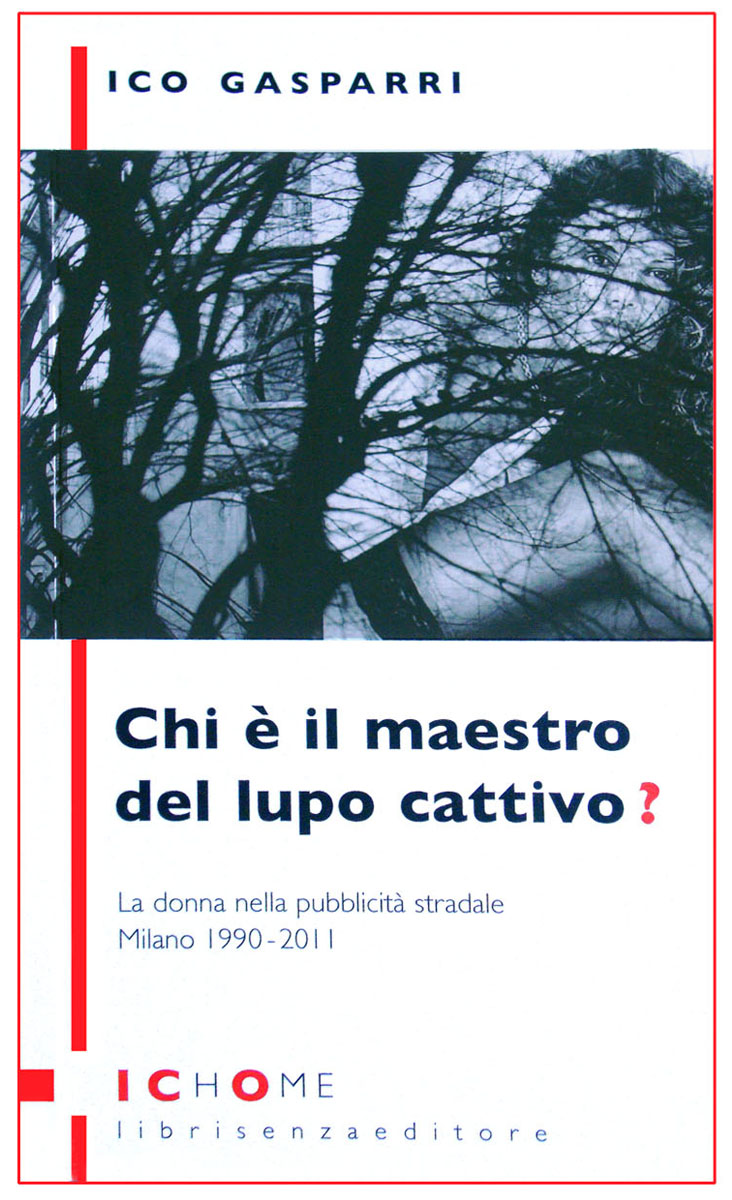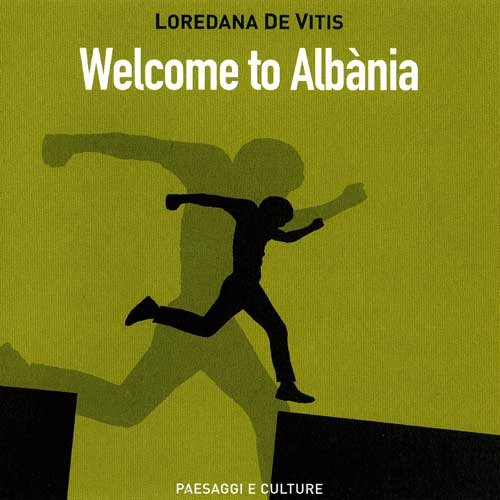Un’amica di un’amica cercava una giornalista che presentasse “un libro sulla Tunisia in cui c’è attenzione per le donne”. È così che ho conosciuto Ilaria Guidantoni. L’ho vista due volte e ci siamo scritte alcune decine di e-mail, ho letto tre dei suoi libri e lei uno dei miei. Ho chiesto di lei, sbircio le sue foto. Il fatto che la trovi sempre ben vestita e pettinata, che porti borse e occhiali firmati, che indossi pellicce e che abbia un piglio sempre piuttosto formale normalmente mi farebbe passare ogni desiderio di approfondimento. Invece Ilaria mi incuriosisce terribilmente: trovo irresistibile il suo innamoramento per la Tunisia. La rende trasparente.
Insomma chi è Ilaria? Dimentica il contesto, qualunque contesto. Definisci chi sei.
«Una donna del Mediterraneo, una specie di apolide. Non lo dico per vezzo: raccontando del Mediterraneo trovo, adesso, il mio riconoscimento maggiore. Culturale ma anche di orizzonte, visione dell’esistenza, complesso di valori morali e religiosi. Vi è una confluenza di anime diverse che è anche nella mia formazione. Amo la sponda a sud del Mediterraneo».
Non riesco a definire “reportage” quello che scrivi.
«No, è una scrittura un po’ di confine. So che è un rischio: assieme alla ricchezza delle differenze che si mescolano, c’è la possibilità del limbo. C’è però una traccia chiara, e cioè il tema dell’“incontro con l’Altro”, presente fin dal primo saggio sulla sicurezza stradale. Certo nell’ultimo – “Chiacchiere, datteri e the. Tunisi, viaggio in una società che cambia” – la scrittura si fa più chiara. È un reportage “caldo”, tutto in prima persona e legato anche a pensieri ed emozioni personali».
Racconti della Tunisia e sei – come si dice in gergo – sempre sulla notizia. Eppure io continuo a trovare più rilevante, più evidente, il dato “personale”. È questo che mi pare definisca il tuo attaccamento a questo Paese.
«Me ne sono innamorata attraverso un incontro personale. Ecco, la vita privata a volte ci porta ad aprire delle porte, poi non è detto che si rimanga nella stessa casa o si esca dalla stessa porta. Io nel frattempo mi sono legata a questo mondo: una vicenda personale mi ha aperto le porte su una vicenda collettiva. Frequentavo la casa di una persona che si occupava (e si occupa) di diritti umani sotto la dittatura: questo ha spalancato un mondo insospettabile. È stato viverlo da dentro, con le preoccupazioni di chi vive una vicenda personale, che probabilmente mi ha portato a scriverne col cuore».
È una storia che continua, insomma, anche se in modo diverso.
«Sai cosa mi succede, adesso? Che frequento molti italiani di Tunisi, italiani nati a Tunisi o che vi vivono in parte o che hanno sposato tunisini. E poi studio arabo e tunisino. Da due anni, anche se con scarsi risultati (sorride, ndr). Il problema è che è molto difficile imparare a parlarlo, vorrei intanto imparare a capirlo. È il passo che voglio arrivare a fare entro un anno. Adesso, scherzando, dico che potrei giocare a nomicosecittà. Conosco, insomma, molte parole. Però l’ultima volta a Tunisi sono andata in un quartiere popolare, ho visto un’insegna, ho riconosciuto che era un ristorante e sono riuscita a leggere il menu in arabo. Mi sono sentita dentro il Paese. Adesso in Italia mi fanno i complimenti per il mio italiano, è buffissimo, mentre a Tunisi la gente mi parla in arabo in qualunque modo io sia vestita. Mi emoziona».
Sei innamorata. Raccontamene i sintomi.
«La malinconia che ho provato le volte che ho lasciato quell’aeroporto. E poi, adesso, se penso al “ritorno” non so di cosa parlo: dell’Italia? della Tunisia? Non so più dov’è questo “ritorno”. Mi era già successo in Italia. Evidentemente un luogo solo non mi basta. Sono in egual misura fiorentina, milanese e romana, ma a parte il legame con la famiglia e la lingua… non riesco nemmeno più a dire d’essere italiana. Altra cosa: a Tunisi riesco a prendere tempo per me. Ecco, forse mi sono innamorata di quel posto perché quando sono lì riesco a non finalizzare il tempo in modo così stringente come faccio altrove. Vivo con un senso di pienezza, quando invece normalmente ho tre telefoni sempre accesi e l’orologio sempre sott’occhio. In Tunisia ho scomposto i miei schemi, proprio come accade quando ci si innamora».
A volte è come se tu dicessi “guardatemi, sono io, sono qui!”.
«Ho molta paura che se… non sto sulla notizia… si dimentichino di me. Ho paura che lontana dai loro occhi possa diventare lontana dal loro cuore. È una forma di corteggiamento, anche. Lo so».
Se ho capito qualcosa di te, ti sei portata in casa un po’ della Tunisia. E parlo di sensazioni.
«Una teiera, un tappeto berbero, gioielli, una sciarpa, una zuppiera, delle coppette dipinte a mano che uso spesso. Ci penso per la prima volta: sono tutti regali. Io non ho mai comprato oggetti per me, per me compro cose che consumo. Il profumo che si utilizza là per i cuscini, il the, vino e aceto balsamico di datteri. Sì, compro cose che consumo, non mummifico la Tunisia».
Ho idea che tu stia provando a spostare parte del tuo lavoro in Tunisia.
«Vorrei cercare di rappresentare, in qualche modo, un anello tra i due Paesi. Turismo, agroalimentare, piccola e media impresa, lavoro femminile. Secondo me ci sono tutti i presupposti per costruire assieme».
[Ilaria Guidantoni ha scritto: “Vite sicure” (Edizioni della Sera, 2010); “Prima che sia buio” (Colosseo Grafica Editoriale, 2010); “I giorni del gelsomino” (P&I Edizioni, 2011); “Tunisi, taxi di sola andata” (NoReply editore, 2012), “Chiacchiere, datteri e thé. Tunisi, viaggio in una società che cambia” (Albeggi Edizioni, 2013)].