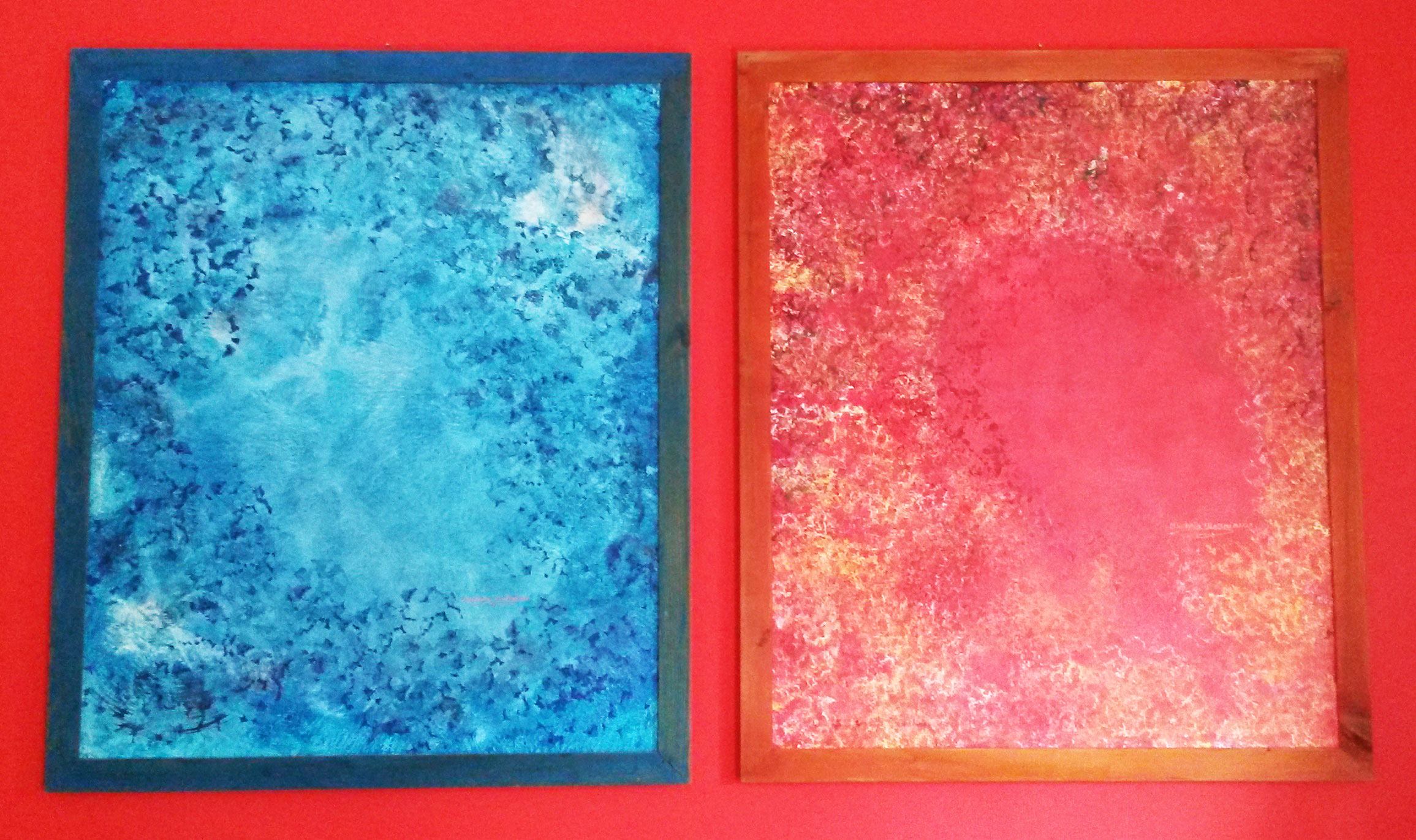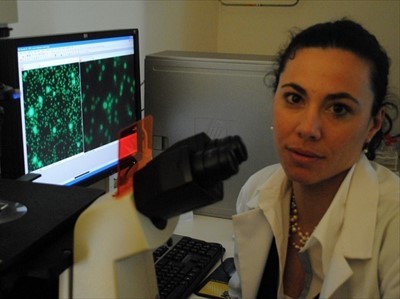Le curiosità, gli interessi, le intuizioni, ma anche l’umanità di un genio che è stato pur sempre figlio del suo tempo sono stati al centro della giornata di studio “Leonardo dall’Officina alla Cucina”, organizzata all’Università del Salento come appuntamento del ciclo di iniziative “Leonardo Da Vinci e la Puglia, tra passato e futuro” promosse per il cinquecentenario della morte dell’inventore, artista e scienziato italiano. L’iniziativa è stata curata dai professori Giulio Avanzini e Paolo Bernardini, del comitato scientifico delle celebrazioni che hanno visto lavorare assieme l’Accademia Pugliese delle Scienze, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento, l’Università della Basilicata, l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Museo Leonardo da Vinci di Galatone (Lecce), Sitael SpA e l’Autorità Portuale di Bari. Il 7 giugno 2019, nella sala conferenze del Rettorato, si è parlato di idraulica, macchine, osservazione dell’infinitamente piccolo e, appunto, di cucina, una delle passioni meno note di Leonardo, sulla quale si è soffermato Maurizio Raselli, “cuoco e piemontese, in quest’ordine”, come ama definirsi.
Maurizio, per parlare di Leonardo proviamo a partire da te. Il tuo ristorante, 3Rane a Lecce, lo racconti come l’approdo di un lungo peregrinare alla ricerca di te stesso. E il nome di questo approdo è ispirato alle esperienze culinarie del Genio. Perché?
Sarebbe bello, forse, raccontare di come possa essere stato illuminato dalla creatività di Leonardo, ma pure se così in qualche modo può esser stato, di certo il lato del Genio che più ci ha entusiasmato è stato quello strettamente terreno, più umano diciamo, meno idealizzato. Il fatto che la leggenda, sotto forma dell’irraggiungibile Codex Romanoff, racconti dell’esperienza di un giovane Da Vinci alle prese con le dinamiche che ben conosciamo alla taverna delle 3 Rane sul Ponte Vecchio a Firenze ci ha fatto sorridere, e forse sentire meno soli. Come dire, nel caso dovesse andarci male, beh potremmo sempre ripiegare sull’Arte (si riferisce, oltre che a se stesso, anche alla compagna Dodo, “partner concettuale” del progetto di ristorazione, ndr).
Leonardo è una delle tue fonti di ispirazione? Il limite tendente a infinito irraggiungibile ma necessario per darsi ogni giorno nuovi obiettivi?
A volte risulta difficile trovare l’origine di un’ispirazione. Alcuni piatti saltano fuori dalle mani come se fossero sempre esistiti, per altri invece il processo è più lungo e macchinoso. Certo quello su cui si può sempre contare è l’ispirazione concettuale, il filo rosso che dovrebbe legare ogni cosa che ruota intorno all’idea di ristorazione che ci si propone. In questo senso l’idea di Leonardo è stata fondamentale.
Dopo anni spesi nella ristorazione cosiddetta di lusso, il fine-dining tanto celebrato e oramai svuotato di ogni dignità, c’era qualcosa che non permetteva al mio meccanismo interiore di scorrere libero. Serviva un punto di rottura. Qui è dove si colloca il genio di Leonardo nel nostro sistema concettuale. A Lecce esisteva da sempre il cibo tradizionale, preparato con più o meno onestà, così come la ristorazione di alto livello. A noi è interessata l’idea di dare a tutti la possibilità di poter godere di un piatto cucinato con competenza a un prezzo trasversale. Così sono nate le 3 Rane, una trattoria gourmet, un piccolo rifugio per amanti del cibo e del vino lontano dall’apparire e dagli stereotipi. Solo piccoli produttori, zero grande distribuzione, vini naturali, contatto diretto e quotidiano con la materia, ambiente informale ma curato, alleggerito. La rottura che vede Leonardo protagonista nella storia del pensiero è stata, con le dovute proporzioni, ispirazione per il nostro concetto trainante di accessibilità.
Per il tuo intervento all’Università del Salento sei partito da un libro che hai raccontato esserti molto caro: “Note di cucina di Leonardo da Vinci”, di Jonathan e Shelagh Routh (edizioni Voland, 2005). Come l’hai scoperto e perché ti ha colpito così tanto?
Immagina una piccola casa, sviluppata in altezza, su tre piani minuscoli con il Mar Ligure che sbatte forte le onde quasi contro i vetri delle finestre. Siamo a Pegli, un minuscolo paesino appoggiato per sbaglio allo sdraiarsi di Genova, dove ho vissuto per anni. Immagina ogni centimetro di questa casa ricoperto di libri, e un pianoforte. Immagina una cucina piccolissima dove sempre qualche capolavoro era in procinto di nascere. Era la casa di Clara e Lello, iperattiva meraviglia lei, grandissimo cuoco lui, come solo un appassionato gourmet può essere. Non uno chef, sia chiaro. Un cuoco. I genitori della moglie di mio fratello, una casa che ho molto frequentato.
Un pomeriggio, tra le migliaia di titoli, ho visto il libriccino. Non ho smesso fino all’ultima riga. Leonardo da Vinci era un uomo. Non una divinità scesa dall’Olimpo, un’Idea astratta e inafferrabile. Passioni, e soprattutto errori. Il genio al servizio del quotidiano, le altitudini del pensiero piegate alle esigenze di tutti così come parti del mondo vero. E poi simpatico, reale. Questo cambio di prospettiva ha scardinato in me, come mille altre volte è successo, un dogma pre-esistente. L’infinitamente grande è anche infinitamente piccolo, come in alto così in basso, come più tardi ho appreso dalla filosofia ermetica. Quella è stata la scintilla. Ci sono voluti più di 10 anni, ma ora cerco di ricordarmelo ogni giorno.
Nella tua relazione era evidente una grande emozione, assieme a un sincero schermirti per essere tra tanti accademici che, al contrario di te, erano in quel momento nel “loro” ambiente. D’altra parte definisci le tue 3Rane come un “ristoro” che propone “cucina artigiana di ricerca”. Insomma, qualche punto di contatto con il mondo dell’università è evidente. Come è arrivata la proposta a intervenire del professor Giulio Avanzini? Cosa ti ha entusiasmato di più dell’idea?
Era difficile non farsi coinvolgere dall’entusiasmo del professor Avanzini. Lui ha dato davvero molto per la riuscita delle giornate leonardesche. Abbiamo un’amica in comune che ha fatto da filo conduttore attraverso le nostre passioni. Oltre la cucina e la mia famiglia, non necessariamente in quest’ordine, ho sempre amato leggere. Si può dire che io sia un piccolo lettore compulsivo, leggo di tutto, da sempre, e appena posso. Mi capita spesso di leggere più libri in un giorno solo, iniziati e finiti, a patto di averne il tempo.
Ho un diploma classico e una laurea in Scienze della Formazione, ma cerchiamo di capirci: sono sempre un cuoco, mediocre per giunta, non un accademico. La proposta di Giulio mi ha lusingato e certo anche un poco preoccupato. Sono avvezzo a parlare in pubblico, nei miei viaggi ho spesso affrontato grandi situazioni sociali in cui mi si chiedeva di intrattenere, anche in inglese, diverse persone. Ma l’argomento era sempre la cucina, la mia cucina. Più comfort di così… invece l’idea di affrontare un tema con un così alto profilo mi ha imbarazzato. Confesso di aver vissuto il mio intervento piuttosto male. Mi sono sentito impacciato e fuori luogo. Certo finché il calore dei professori coinvolti non mi ha sostenuto. Di questo conservo un meraviglioso ricordo, e un grande senso di supporto. Del resto aiutare le menti a evolvere credo sia uno dei traguardi dell’Università.
Tra i piatti consigliati della tua cucina leggo “Ravioli del plin ripieni di fegatini di pollo, sedano rapa in crema e bollito, battuto di podolica pugliese”. Ma Leonardo non era vegetariano? Scusami la battuta, mi interessa parlare del tuo approccio alle materie prime.
Beh, se l’alternativa fossero le folaghe molto frollate o i testicoli di montone al latte credo che considererei l’alternativa vegetariana anch’io… o forse almeno per la colazione, venerando da piemontese ogni singola vena di grasso della carne ben marezzata! A parte le battute, si discute ancora sull’etica alimentare di Leonardo. Non credo fosse completamente vegetariano, almeno non nella concezione moderna del termine dove il Principio viene sempre più spesso posposto rispetto alla moda. Certo amava il bello e il buono, in ogni loro forma, dunque credo non amasse il cruento attimo proprio della macellazione ma era sempre un uomo del XV secolo. Il sangue era piuttosto comune, certo più del tofu.
L’ingrediente esige rispetto, competenza e tecnica, oltre a un’immensa dose di amore.Conosco macellai che amano in un modo viscerale le bestie che poi diventano il medium del loro lavoro. Persone spinte da un’etica integerrima, che offrono più amore agli animali che sanno poi se ne andranno, perché questo è quello che sono, di quanto non facciano vegetariani di ora che magari non mangiano il pesce ma ostentano cinture di pelle di vitellino senza nemmeno soffermarsi sul significato delle parole. Dignità e coerenza sono sempre più importanti, nella scelta dell’ingrediente, del piatto e nella vita in generale.
Io conosco personalmente tutte le persone che aiutano la natura a produrre ciò di cui mi servo per cucinare. Conosco chi spreme le olive per il mio olio, chi pigia l’uva per i vini che amo, chi zappa la terra per le verdure che compro e chi macella gli animali che cucino e mangio. L’ingrediente principale è l’etica del cuoco.
Le recensioni sulla tua cucina e il tuo ristorante dicono di una capacità di tenere assieme gli opposti – lato cucina – e di una grande gentilezza e ospitalità – lato accoglienza. Come sei arrivato a questa formula? A guidare ogni passo sembra essere essenzialmente la tua personalità.
Anthony Bourdain scriveva che le cucine tendono ad assomigliare agli chef che le guidano. Credo sia una grande verità estesa poi al ristorante tutto, se il cuoco è anche il gestore o il proprietario della struttura. È vero, le 3 rane mi assomigliano, moltissimo. C’è molto di imperfetto, ma non di lasciato al caso. L’idea della perfezione occidentale è un concetto limitante. Lo scintillio preconfezionato da discount della creatività. Il perfetto non include il suo opposto, il manchevole. L’imperfetto è necessario. Le crepe delle porcellane in Asia valgono più dei vasi stessi, perché li rendono vivi, con una storia. Da noi questo problema non si pone. Le 3 rane sono un bel posto, ma restano un’osteria, una trattoria. Dove l’oste o il trattore sono quelli che decidono, ma che anche mettono in gioco tutto il loro essere.
Io ho costruito il locale, fisicamente. Mi sono costruito da solo i banconi, ho messo io il pavimento, gli impianti, mi sono montato da solo la cucina che era stata lasciata sul marciapiede da uno zelante corriere. Ho disegnato il locale, la cucina. Ho abbattuto pareti e costruite di nuove. Ho dipinto, rasato, avvitato, tolto e messo quasi tutto quello che si vede. Ho sanguinato, fisicamente, ho pianto in alcuni momenti e riso in altri. La mia fidanzata Dodo stava aspettando il nostro bimbo, nato a fine dicembre del 2017 mentre io costruivo il locale. Ci ho messo 5 mesi. Un bambino è nato a dicembre, Martino. L’altro nel marzo successivo, le 3Rane.
Credo che questo abbia influito molto nel creare l’atmosfera di reale identità che ora si respira tra inostri 6 tavolini. Io mi sentirei di consigliarlo a chi dovesse essere così pazzo da ascoltarmi. Costruite il vostro locale con il sangue e il sudore, ogni goccia versata tornerà come nutrimento per la nascita della sua propria identità.
Leggendo la tua biografia sembra che tu abbia lavorato praticamente ovunque. Quali credi siano state le esperienze più importanti, e perché?
Ma no, quale ovunque! È vero, ho viaggiato. Ho sacrificato molto per imparare. Ma molti altri hanno fatto il mio stesso percorso. La vita di uno chef può sembrare folle a chi non è del mestiere. Orari impossibili, fatica sovrumana, calore insopportabile, anni e anni di apprendistato alle corti di chef spesso bipolari, aggressivi, egotici e violenti senza alcuna dignità riconosciuta se non rapportata alla capacità di sopportare tutto questo. Io ho cominciato molto presto: 16 anni, nei fine settimana, quando magari il sabato mattina sarei stato interrogato al Liceo nell’ora di Greco, la sera prima stavo lavando bicchieri alle due di notte. La cosa strana è che non lo facevo per necessità. La mia famiglia ha sempre provveduto ai miei bisogni di ragazzo. A volte addirittura mentivo per andare a lavorare. Forse sono sempre stato cosciente del processo di costruzione della mia competenza. Sapevo di dover sacrificare.
Poi l’Europa, l’Inghilterra e la Scozia, le Maldive, l’India, la Russia, in Siberia… più di dieci anni di solitudine e ricerca di qualcosa. Ogni esperienza è stata propedeutica a quella successiva. Ora sono un cuoco, è vero, ma soprattutto sono un marito e un padre. Ringrazio ogni istante di solitudine e sacrificio se mi hanno permesso di guardare dormire il nostro bambino la notte, quando rientro.
Lecce è il tuo approdo e la tua base. L’amore è la tua guida in ogni scelta, in cucina come nella vita? Quali progetti hai per il futuro?
Il rapporto tra la mia compagna e me è basato su una reciproca comprensione, una grande complicità. Ci assomigliamo molto, anche se lei non lo ammetterebbe mai!Entrambi con radici solide, ma anche con rami aerei, per così dire. Lecce è il presente, il futuro verrà da sé. A me basta stare con loro, poi il mestiere è nelle mani come dicono i Maestri.
Se ho cucinato un risotto per Sua Maestà Luminosa il Re del Ladack, nel palazzo reale di Leh, al confine tra Himalaya e Cina, su un buco in terra dove avevo acceso un fuoco con le sterpaglie trovate in terra, a quasi 3500 metri di altitudine sotto una tempesta di pioggia dell’autunno del Karakorum, credo di poter, ripeto credo, cucinare qualcosa quasi ovunque. Per ora, però, il presente ha ancora molto da dare.
Consigliaci un menu leonardesco da provare, magari, proprio nel tuo ristorante.
Menù leonardesco? Riporto quello che Leonardo, allora maestro di cerimonia alla corte degli Sforza, propose a Ludovico il Moro in occasione di una festa tenutasi in onore di una nipote del Signore:
un involtino d’acciuga in cima a una rondella di rapa scolpita a mo’ di rana
un’altra acciuga, avvolta attorno a un broccolo
una carota, bellamente intagliata
un cuore di carciofo
due mezzi cetrioli su una foglia di lattuga
un petto di uccello
un uovo di pavoncella
un testicolo di pecora freddo alla panna
una zampa di rana su una foglia di tarassaco
uno stinco di pecora cotto sull’osso
…e io, piccolo cuciniere ignorante, che mi ostino a fare i ravioli!
quest’intervista è stata originariamente realizzata per il periodico dell’Università del Salento “Il Bollettino” (settembre/ottobre 2019)
la foto di Maurizio Raselli è di Sonia Gioia (per gentile concessione)