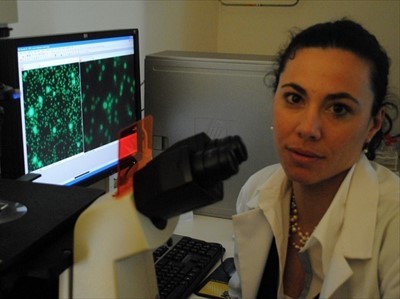Il professor Mario Capasso, ordinario di Papirologia all’Università del Salento, ha fondato e dirige il Centro di studi papirologici e il Museo papirologico dell’Ateneo. Delegato ai Musei dal 2008 e Presidente nazionale dell’Associazione di Cultura classica, è direttore – con Paola Davoli – della missione archeologica UniSalento a Dime (Fayyum, Egitto).
Professor Capasso, il suo è un mestiere che coincide così chiaramente con una grande passione che viene naturale partire dalla più ovvia delle domande. Com’è cominciata?
«Ho cominciato seriamente a pensare di dedicarmi al mestiere di papirologo frequentando i corsi di Papirologia all’Università di Napoli, negli anni Settanta del secolo scorso: mi affascinava il contatto diretto con il testo antico, la sfida, se posso usare questo termine abusato, che la sua decifrazione in qualche modo lancia a colui che ha il compito di decifrarlo. Decifrare per la prima volta un testo è stabilire un contatto diretto con colui che lo ha scritto o fatto scrivere, una persona vissuta molti secoli fa».
In vent’anni di scavi, abbiamo visto scoprire al suo gruppo di lavoro numerosi reperti importanti in modo costante. Quali sono i segreti di una così prolifica attività di ricerca?
«Non ci sono segreti in questo mestiere: occorrono passione, entusiasmo, abnegazione, fiducia. Quando sono impegnato in Egitto per l’annuale Campagna di Scavo, mi sveglio al mattino pensando che quel giorno sarà un gran giorno, un giorno di una grande scoperta. Poi magari la grande scoperta non si verifica, ma quale altro lavoro può definirsi altrettanto esaltante?».
Come descriverebbe l’emozione della più recente scoperta? Si prova sempre lo stesso sentimento?
«L’emozione che si prova nello scoprire un oggetto importante, che sia un papiro o una statua, è qualcosa di elettrizzante, una sorta di euforia, che ripaga dei tanti sacrifici che questo nostro mestiere ci impone. La scoperta dei due leoni è stato un momento esaltante, per noi dello staff, ma anche per gli operai, umili contadini che per poche lire egiziane al giorno svolgono un lavoro certamente faticoso, ma che sono orgogliosamente consapevoli del loro ruolo».
Parliamo della recente conferma alla presidenza nazionale dell’Associazione di Cultura Classica. Di cosa si occupa, in dettaglio, l’associazione?
«L’AICC, nata nel 1897, si prefigge di tutelare e divulgare le nostre gloriose tradizioni classiche. Organizza congressi, gare di greco e di latino, seminari, conferenze, viaggi di studio. Soprattutto vigila affinché le nostre discipline classiche siano adeguatamente rappresentate nell’ordinamento scolastico e in quello universitario».
Cosa della classicità crede che manchi di più?
«Delle tante definizioni che si possono dare della classicità mi piace quella che vuole che la classicità è il rispetto per l’uomo, la fiducia nella centralità dell’individuo, del suo pensiero, dei suoi sentimenti, della sua libertà. Al giorno d’oggi si tende a perdere di vista tutto questo, che rappresenta il grande insegnamento lasciatoci dagli antichi».
In un panorama di sempre più scarsi finanziamenti per la ricerca scientifica, quanto soffre la ricerca “umanistica” rispetto a quella – per esempio – con applicazioni per l’industria?
«La ricerca umanistica soffre moltissimo rispetto a quella scientifica, che, va detto, pure non gode di ottima salute, ma certo dispone di più risorse. Si tratta di una situazione non solo italiana ma certo in Italia, che è la culla della cultura umanistica e che riserva una percentuale irrisoria, appena lo 0,19% del PIL per la tutela del suo patrimonio culturale, noi umanisti viviamo una situazione che non esito a definire drammatica».
Lei lavora con giovani ricercatori e ricercatrici e tanti appassionati. Qual è l’augurio che si sentirebbe di rivolgere?
«Che con la fine di questa devastante crisi internazionale i fondi messi a disposizione delle Università possano tornare almeno a livelli decorosi, in modo che questi giovani possano concretamente sperare di dedicarsi serenamente alle loro ricerche: abbiamo già perso più di una generazione di giovani eccellenti; considero questo una sorta di peccato mortale verso di essi ma anche verso il futuro dell’Italia».
quest’intervista è stata originariamente realizzata per il periodico dell’Università del Salento “Il Bollettino”
nell’immagine i professori Capasso e Davoli con lo staff di ricerca in Egitto