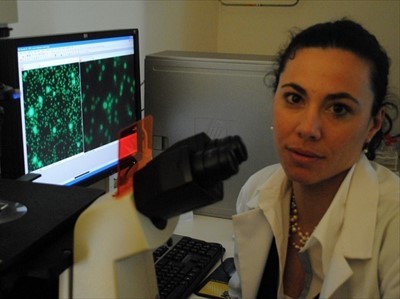Dall’Italia alla Germania e ritorno, tre diversi “focus” di ricerca dalla laurea al contratto come ricercatrice al CNR-Nano di Lecce, 22 pubblicazioni su riviste scientifiche peer-review, un brevetto internazionale. Se vi pare già abbastanza per una trentatreenne, ecco la “notizia”: Loretta del Mercato è tra i vincitori del premio ‘Tr35 giovani innovatori’ promosso da ‘Technology Review’. Stiamo parlando della rivista per l’innovazione del Mit – Massachusetts Institute of Technology, che punta a raccogliere il meglio delle idee innovative e dei progetti di ricerca applicata e che in Italia gestisce il premio in collaborazione con il Forum Ricerca Innovazione. «Ho anche un bambino di nove mesi», aggiunge Loretta sorridendo.
Loretta, non riesco a non cominciare dalla più classica delle domande. Con la scienza è stato subito amore?
(sorride, ndr) «Ho capito che volevo occuparmi di scienza e di ricerca quando frequentavo il Liceo classico, ma da piccola amavo trasmissioni come Viaggio nel corpo umano. Eh, sai, Piero Angela… (ride, ndr). Comunque al momento della scelta universitaria ero in dubbio: medicina o qualcosa di più sperimentale? Alla fine ho iniziato a studiare Biotecnologie agrarie a Napoli, e mi sono laureata con una tesi sperimentale producendo piante transgeniche. Dopo la laurea mi sono però resa conto che in Italia – come in Europa – le biotecnologie vegetali erano condannate: per il cosiddetto “principio di precauzione”, occorreva dimostrare che il prodotto transgenico non fosse nocivo con ben dieci anni consecutivi di ricerche. Insomma, non ci vedevo un grande futuro».
E qui il primo cambiamento.
«Sì, ho pensato di usare il dottorato per “spostare” il campo di ricerca. È importante, anche perché si acquista flessibilità. All’inizio si può fare, soprattutto dopo la laurea si è piuttosto versatili. Ora, poiché il mio allora fidanzato e adesso marito è di Lecce, guardando i vari bandi di dottorato in Italia mi soffermavo anche su quelli dell’Università del Salento. C’era un concorso all’Isufi, presso il Laboratorio nazionale di nanotecnologie, un dottorato in Materiali e tecnologie innovative, perciò sono venuta a visitare l’Istituto. Ne sono rimasta molto colpita: una realtà internazionale, seminari in inglese, ricercatori con background diversi che lavoravano assieme… qualcosa di simile alla Silicon Valley, mi sembrava l’America. Insomma ho scelto Lecce preferendola a dottorati altrettanto validi, come quello alla Sissa di Trieste. Nel corso del dottorato, per farla breve, sono passata alla bioelettronica. Si trattava di creare dispositivi elettronici utilizzando materia biologica come proteine e fibrille. Lavoravo con alcuni fisici. Il mio tutor era la professoressa Rosaria Rinaldi, e poi c’era il professore Roberto Cingolani come responsabile del dottorato».
Dopo il dottorato, però, hai cambiato ancora. Perché?
«Il post-doc è una fase in cui hai ancora qualche possibilità di cambiare, cosa che è utile soprattutto per arricchire il tuo bagaglio scientifico. Perciò mi sono “spostata” di nuovo, verso la scienza dei materiali applicata (anche) alla medicina. Sono stata a Marburgo, in Germania, a lavorare con il professor Wolfgang J. Parak: full professor a 40 anni, aveva fatto il post-doc a Berkeley nel campo delle nanoparticelle per applicazioni biomediche. Ci ho lavorato per due anni e tre mesi, con l’incarico di formare – all’interno del gruppo più grande – un mini-gruppo di ricerca, composto da un dottorando di fisica, due studenti di fisica e una tesista di chimica. Si trattava di sintetizzare le capsule di cui mi occupo tuttora. Il professore voleva cominciare a utilizzare questi sistemi, già a regime in diversi laboratori nel mondo, nel suo. Ho letto tanti articoli e fatto tante prove».
Per due volte hai cambiato settore di ricerca, e senza preparazione iniziale specifica. Qual è stata la tua “arma” vincente?
«Io credo che i miei mentori abbiano valutato soprattutto l’impegno, la volontà di fare bene, la voglia d’essere innovativa. L’andamento dei finanziamenti per la ricerca è chiaro: ora è il momento dell’elettronica, ora quello della nanomedicina, ora quello delle energie rinnovabili. Il mio interesse generale è per la ricerca applicata, e da tre anni a questa parte mi appassiono sempre di più allo sviluppo di materiali intelligenti per curare malattie del corpo umano».
È con un’applicazione del genere che hai vinto il premio.
«Sì, sensori ottici fluorescenti costituiti da capsule di dimensioni inferiori a quelle del diametro di un capello. All’interno delle capsule abbiamo inserito delle molecole fluorescenti sensibili alle concentrazioni di ioni potassio, sodio e di protoni. Queste molecole, che sono vendute dalle aziende e utilizzate per tanti altri studi, emettono luce a intensità diversa a seconda dell’elemento che leggono in una soluzione. All’esterno delle capsule abbiamo applicato delle “etichette” con miscele diverse di nanoparticelle fluorescenti, più piccole di un virus, che fungono da codici a barre, come quelli utilizzati per catalogare i prodotti in vendita nei negozi. Queste “etichette” luminose consentono l’identificazione univoca del tipo di sensore in esame, mentre l’interno della capsula identifica le molecole nella soluzione misurandone la concentrazione. La novità di questa ricerca consiste nell’avere aggiunto al materiale una funzione nuova, una proprietà che prima non aveva, utilizzando una tecnologia a basso costo».
Ci spieghi come viene utilizzata?
«Posso fare l’esempio di un’industria farmaceutica che vuole testare l’efficacia di una serie di composti terapeutici per il trattamento di determinate malattie. Una possibile soluzione per farlo è incubare le cellule con i nostri sensori. Si trattano le cellule con i diversi composti che vuole testare l’industria, e si studia la risposta delle cellule ai trattamenti. Esposta a un farmaco, infatti, nella cellula si innescano processi biochimici evidenziati da cambiamenti di concentrazione di determinate molecole. La cellula trattata, per esempio, produce più protoni. È un bene? È un male? È quello che volevamo in risposta a questo trattamento? Noi forniamo degli strumenti al ricercatore o all’industria per verificare qual è l’effetto dei trattamenti sulle cellule».
Quali sono le ulteriori prospettive di ricerca?
«Dovremo creare un dispositivo ancora più sofisticato, al quale aggiungere un’altra funzione. Finora ne abbiamo inserite due: la capacità di monitorare elementi diversi e l’etichetta luminosa esterna. La terza funzione sarebbe quella di avere all’interno di queste capsule anche il farmaco, perché possa essere rilasciato – volendo – dall’esterno. Un operatore al microscopio potrebbe monitorare la situazione della cellula che vuole trattare misurando la risposta della capsula, e irradiare la cellula in un determinato momento. La capsula, a quel punto, si romperebbe rilasciando il farmaco trasportato».
Quanto tempo potrebbe volerci?
«Dipende da quanti soldi avremo a disposizione. Al momento sto valutando l’interesse di alcuni venture capital che ci hanno chiesto qual è la fattibilità del progetto, a che stadio siamo, se siamo più interessati a un city incubator oppure se siamo pronti a fare una start up. Vedremo».
Come è organizzato il tuo lavoro attualmente?
«Ho dei tesisti che vanno e vengono, e questo è un grande ostacolo. Bisogna formarli, ma senza budget per mantenerli bisogna ricominciare daccapo con i successivi. Sono pause che pesano moltissimo: non si può avere un gruppo costante di ricerca e si “sciupa” il fattore umano. Così è successo quando dalla Germania ho portato know how in Italia. La precarietà organizzativa si ripercuote sulla ricerca e sulla crescita scientifica dei ragazzi che le si accostano. Io stessa ho avuto piccoli contratti che si rinnovano a brevi intervalli. Non sai mai quali piani di ricerca impostare a medio termine, la precarietà è un ostacolo molto forte per le persone e anche per l’immagine della ricerca italiana all’estero, dove questo è inimmaginabile».
Che cosa fa realmente la “differenza” quando si fa ricerca? Tra donne e uomini? Tra l’Italia e la Germania?
«Certi risultati non si ottengono lavorando otto ore al giorno, bisogna farne 12 e più, che tu sia donna oppure uomo. I tempi di certi sperimenti lo esigono, bisogna lavorare duramente e di continuo. Ho sempre dedicato tanto tempo alle mie ricerche, anche durante gli anni di tesi a Napoli e di dottorato a Lecce, molti weekend li passavo in laboratorio. In Germania però è migliore l’organizzazione sociale, questo sì, in Italia non ci sono abbastanza servizi per le famiglie, e quelli privati sono molto costosi rispetto agli stipendi. In Germania, a parità di incarico, lo stipendio è più alto se hai famiglia, e questo è un aiuto perché ti puoi per esempio permettere una baby sitter. In questo modo puoi lavorare con maggiore serenità, senza dover sacrificare figli e marito ai tempi della ricerca, come purtroppo sono costretta a fare io. E poi lì conta molto quello che produci, le piste di ricerca, gli obiettivi che presenti, diciamo che l’organizzazione invece di essere il maggior ostacolo ti sostiene e ti spinge».
quest’intervista è stata originariamente realizzata per il periodico dell’Università del Salento “Il Bollettino”