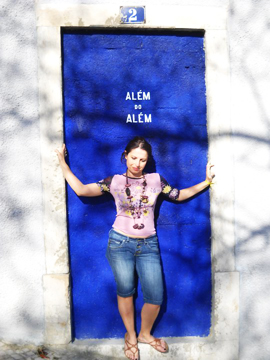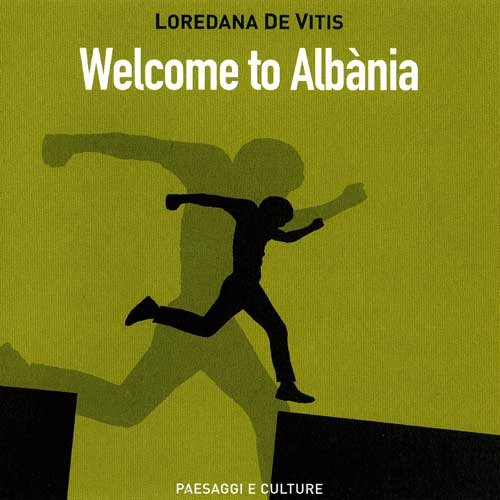Sabrina Barbante si è sempre giocata (assai male) la storiella d’essere banale, noiosa, prevedibile. Potreste sentirla raccontare questa storiella e riferirla – con grande probabilità – ai suoi capelli, per esempio. «Mai tagliati, sempre uguali da sempre». Potreste sentirla raccontare questa storiella a proposito del suo uomo: «Ero la più noiosa, la più prevedibile. Ma tant’è». Potreste sentirla raccontare questa storiella per un’altra infinità di motivi ma non credo vi convincerà. Perché in genere mentre racconta questa storiella fa tintinnare un nuovo paio di orecchini improbabili (tipo i miei), o agita una gonna a quadri in stile very Scottish, e poi – veniamo al punto – soprattutto Sabrina scrive. Racconti, romanzi, articoli, testi su blog vari (non solo il suo). Scrive continuamente, scrive ogni giorno.
Insomma, Sabrina, falla finita con questa storia. Parliamo del tuo secondo romanzo, Faintly falling, e vediamo di non girarci intorno. La neve fa rumore, dici nel sottotitolo. La faccenda non è banale.
«La neve dice dell’immobilità, racconta la paura della paura di cambiare. Le persone si chiudono nei propri riti, nei propri doveri, si addormentano. Ho riti anch’io, per esempio prendo un caffè doppio macchiato da portare via ogni mattina nello stesso bar. La china che prendono queste cose, l’immobilità… mi ha sempre fatto paura. Ecco».
La neve descrive, circonda, amplifica l’immobilità delle sorelle protagoniste del romanzo. Un’immobilità apparente o reale? A me sembra che, alla fine, almeno una delle due salvi se stessa e così facendo salvi entrambe dal… nulla. E James, poi, quest’uomo molto affascinante che entra nella loro vita: James viaggia.
«Sì ma anche il viaggiare è un rito per non tornare al nocciolo della questione. Una cosa che accade se non hai il coraggio di riportare tutto a casa. Per quanto riguarda Laura e Cristina, ecco… nel loro caso è il troppo amore che blocca. Il troppo amore blocca sia che tu lo nutra sia che tu ne sia oggetto. Rimaniamo così, chiusi nella fissità della nostra esperienza».
Non descrivi nei dettagli James, ma sappiamo bene che stai parlando di Joyce. Lo dichiari in quarta di copertina addirittura: dici che questo romanzo è un saldo di conto in sospeso.
«Avevo 14 anni quando ho letto The Dead, e mi ha sconvolto l’esistenza. Ho due debiti con Joyce. Il primo è per questo racconto, perché quando sono arrivata all’ultima riga mi sono detta: non voglio mai, nella vita, arrivare a guardarmi indietro e rendermi conto che certe cose non le ho volute vedere. E il secondo debito, che non ho saldato e non salderò mai, è un debito con il suo stile. Come si fa? La sua grandezza… non si raggiunge, e questo ti lascia senza fiato. La coscienza che mai potrai. È dura».
Mentre parliamo, io e Sabrina beviamo. Birra. Siamo in un pub di Lecce dove la Guinness è ben spillata. Io ne ho presa una pinta. Sabrina ha preferito una bionda. Dal bancone si avvicina una delle ragazze a portarci due cicchetti di rhum. Dice: «Da parte di un ragazzo, non vuole che vi dica chi è». Sabrina è sconvolta. Mi dice: «Solo quando esco con te mi capitano queste cose». Chissà se è vero, comunque è divertente.
Sabrina, perché i tuoi personaggi sono sempre così… composti? (Sabrina ride). Dai, sono composti. Io leggo te, leggo me e mi metto le mani nei capelli. I miei sono sempre in delirio. I tuoi sono… composti. Ti piace questa definizione?
«Adesso cosa posso dire per non compromettermi?».
Risate.
«Oddio, sono in un cul de sac».
Risate.
«Forse perché non ho ancora maturato distacco. Distacco da quello che ci si aspetta da me. Ma la verità è che una vita non mi basta, vorrei vivere mille vite parallele. Scrivere è catartico, distogli l’attenzione da te stessa».
È così che la neve cade. Lentamente cade. Sul passato e sul presente, sui vivi e i morti: the flakes, silver and dark, falling obliquely against the lamplight. E ora torniamo a casa.